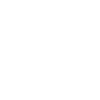Dopo più di 22 anni, non potremo più vedere l’universo attraverso gli occhi di Integral. Occhi molto speciali in grado di vedere le lunghezze d’onda energetiche dei raggi gamma, la cui vista dalla Terra è impedita dalla presenza dell’atmosfera. Occhi che ci hanno consentito di studiare fenomeni misteriosi come i gamma ray bursts, per comprendere che quelli “più lunghi”, che durano diversi secondi, potrebbero essere dovuti al collasso spontaneo di stelle massicce che diventano supernove, mentre quelli più brevi a buchi neri e stelle di neutroni che si scontrano tra loro. Non solo, il telescopio ha catturato il lampo gamma più luminoso mai osservato, avvenuto in una galassia distante quasi due miliardi di anni luce.

Rappresentazione artistica del telescopio spaziale Integral dell’Esa. Il satellite ha un’altezza di circa 9 metri con pannelli solari larghi 15 metri, per un peso totale di 3600 kg. Crediti: Esa
«Veramente difficile da digerire, dopo trent’anni anni dall’approvazione da parte di Esa della realizzazione dell’Osservatorio spaziale Integral, che la missione venga terminata», commenta amareggiato a Media Inaf Pietro Ubertini, principal investigator dello strumento Ibis a bordo del satellite. «In realtà, dal momento che il telescopio ha da poco iniziato una nuova orbita, impiegherà tre giorni per arrivare all’apogeo a 153 mila chilometri dalla Terra (per poi tornare indietro) e continuerà a trasmettere dati scientifici fino all’ultimo. Poi, una volta raggiunto il punto più vicino alla terra entrerà in eclisse il 4 marzo e per sei ore sarà alimentato dalle batterie di bordo. Da quel momento non invierà più dati scientifici a terra. Dal punto di vista del satellite però non cambia molto, perché rimarrà attivo, ma cambierà tutto per la comunità scientifica mondiale delle alte energie. Tecnicamente il centro di controllo di Esoc [il centro controllo missioni dell’Agenzia spaziale europea a Darmstadt, in Germania, ndr] dovrà controllare che tutto funzioni come prima: per poter assicurare un rientro sicuro anche gli strumenti scientifici saranno operativi perché necessari al corretto bilancio termico. L’unica differenza sarà l’interruzione della trasmissione dei dati scientifici. Anche questo difficile da digerire. Per risparmiare meno dell’un per cento del costo della missione non riceveremo più dati definiti “outstanding”, di grande valore scientifico. Basti pensare che per l’ultimo anno di osservazioni l’Esa ha ricevuto da astrofisici di tutto il pianeta proposte scientifiche che richiedono quattro anni di osservazioni di Integral».
Integral era stato lanciato il 17 ottobre 2002 dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan. Al momento del lancio era il più avanzato osservatorio di raggi gamma e il primo osservatorio spaziale in grado di vedere oggetti celesti contemporaneamente nei raggi gamma, nei raggi X e nella luce visibile. Il telescopio è – o forse dovremmo dire era – dotato di un campo visivo molto ampio che copre circa 900 gradi quadrati di cielo nei raggi X e gamma più energetici, ed è in grado di produrre, simultaneamente, immagini e spettri dettagliati alle energie più elevate, aiutandosi con camere a raggi X e ottiche per individuare le sorgenti di raggi gamma.

Pietro Ubertini (Inaf), principal investigator dello strumento Ibis a bordo di Integral, durante i test pre-lancio del satellite nella clean room al centro spaziale di Esa-Estec, in Olanda, nel dicembre 2001. A sinistra la maschera codificata di tungsteno utilizzata per ottenere le prime immagini in raggi gamma ad elevata risoluzione delle sorgenti cosmiche osservate. Crediti: Angela Bazzano
Ed è grazie a questo se il telescopio si è mostrato lo strumento giusto anche per svolgere osservazioni per le quali non era stato concepito. Fra tutte, la capacità di rintracciare le sorgenti nel cielo che hanno generato alcune delle onde gravitazionali e dei neutrini ad altissima energia catturati dagli strumenti specializzati a terra. Al momento del lancio di Integral non si era nemmeno sicuri che le onde gravitazionali potessero essere rilevate direttamente: la loro prima osservazione è stata effettuata 13 anni dopo, dai rilevatori di onde gravitazionali Ligo negli Stati Uniti, nel 2015. E nemmeno due anni più tardi Integral, insieme al satellite Fermi della Nasa, ha registrato un segnale in raggi gamma 1,7 secondi dopo l’arrivo delle onde gravitazionali dell’evento Gw 170817 – il primo, e a oggi unico, evento di astronomia multimessaggera di questo tipo.
Concludiamo quindi la Hall of fame di Integral con altre due targhette: recentemente il telescopio ha anche guidato intuizioni uniche su come le esplosioni termonucleari guidano i getti nelle stelle di neutroni e ha catturato la rarissima esplosione di una magnetar extragalattica, che ha emesso una quantità di energia pari a quella prodotta dal nostro Sole in mezzo milione di anni che ha addirittura perturbato l’alta ionosfera terrestre. In tutto il segnale registrato è durato meno di un secondo, sufficiente però per una scoperta pubblicata su Nature Communications.
«Dopo oltre 2886 orbite e 22 anni di osservazione delle profondità del nostro cosmo, oggi i sensibili strumenti di Integral smettono di raccogliere dati scientifici. Ma l’eredità dell’osservatorio di raggi gamma dell’Esa servirà agli scienziati per molti anni ancora», conclude Matthias Ehle, mission manager di Integral all’Esa. «La ricchezza di dati raccolti in due decenni sarà conservata nell’Integral Science Legacy Archive. Sarà essenziale per la ricerca futura e per ispirare una nuova generazione di astronomi e ingegneri a sviluppare nuove entusiasmanti missioni».
A questo punto, una domanda doverosa per la fine di una missione spaziale. Che fine farà Integral, ora che non trasmette più dati scientifici? Quando il telescopio è stato lanciato, nel 2002, l’Agenzia spaziale europea non prevedeva alcuna procedura di deorbiting dei suoi satelliti per evitare che questi, una volta dismessi, diventassero spazzatura spaziale. Nel 2015 però, il team dell’Agenzia spaziale europea che controllava il volo di Integral si rese conto che eseguendo una manovra specifica per modificare l’orbita si sarebbe potuto evitare che il telescopio rimanesse, al suo spegnimento, un detrito spaziale per i secoli a venire. Una manovra che, inaspettatamente, complicò la vita del telescopio, ma che garantirà il naturale rientro di Integral nell’atmosfera terrestre nel 2029, fra quattro anni.
Come mai questa manovra complicò la vita del telescopio? Se avete ascoltato la puntata di Houston (il podcast di Media Inaf) “Tre ore per salvare Integral” già lo sapete: a causa del propellente impiegato per modificarne l’orbita durante quella manovra – e in seguito a un problema avvenuto a maggio 2020 – da quasi cinque anni il telescopio spaziale vola senza propulsori, capovolgendosi regolarmente per scaricare le ruote di reazione e mantenere la stabilità operativa. Una procedura mai pensata prima al centro di controllo dell’Esa a Darmstadt, che ha trovato un ottimo compromesso con le osservazioni e che ha impedito la sua prematura fine e altri quattro anni e mezzo di osservazioni.
Se volete saperne di più su questa vicenda, potete ascoltare la puntata del podcast sul canale Youtube MediaInaf Tv al link qui sotto oppure su Spotify o Apple podcast.