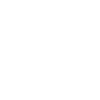Che siano state delle esplosioni di supernove a spazzare via per ben due volte la gran parte delle forme di vita dalla faccia della Terra? Non è la prima volta che le supernove si ritrovano sul banco degli imputati insieme a indagati altrettanto spaziali quali asteroidi e lampi di raggi gamma, la teoria aleggia da tempo nell’ambiente scientifico. Ma a corroborare questa ipotesi arrivano ora i risultati di un nuovo studio: tre ricercatori della Keele University (Regno Unito) hanno infatti notato una corrispondenza temporale tra due eventi di supernove e due grandi estinzioni di massa avvenute centinaia di milioni di anni fa sul nostro pianeta.
Gli eventi di cui stiamo parlando sono l’estinzione del tardo Devoniano e quella dell’Ordoviciano, avvenute rispettivamente 372 e 445 milioni di anni fa. L’estinzione dell’Ordoviciano uccise il 60 per cento degli invertebrati marini in un periodo in cui la vita era prevalentemente confinata nel mare, mentre quella del tardo Devoniano spazzò via attorno al 70 per cento di tutte le specie. All’origine di questi avvenimenti c’è probabilmente una riduzione dello strato d’ozono che avvolge la Terra, ma non si hanno ancora prove certe su cosa l’abbia provocata. Alcuni studiosi ritengono che la responsabile potrebbe essere stata, appunto, la potentissima esplosione di una supernova vicina alla Terra.

Esplosione della supernova Sn 1987a (al centro) nella Grande Nube di Magellano, una galassia vicina alla nostra Crediti: Nasa, Esa, R. Kirshner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and Gordon and Betty Moore Foundation), M. Mutchler and R. Avila (STScI)
Gli autori dello studio, pubblicato la scorsa settimana su pubblicato su Monthly notices of the Royal Astronomical Society, stavano portando a termine un censimento delle stelle massive entro un kiloparsec (circa 3260 anni luce) di distanza dal Sole, analizzando in particolare la distribuzione delle stelle di tipo OB, per comprendere meglio l’origine degli ammassi di stelle e delle galassie e per analizzare la frequenza con cui queste stelle si formano nella nostra galassia. Un censimento che ha permesso loro di calcolare anche la frequenza con cui avvengono le supernove e la produzione di resti di supernova e di resti di stelle massive attraverso l’universo, come ad esempio buchi neri e stelle di neutroni. Ed è proprio nel corso di questo “inventario stellare” che si sono imbattuti, appunto, in una possibile correlazione tra supernove ed estinzioni di massa.
Rifacendosi all’ipotesi delle supernove distruttrici di vita, i tre ricercatori hanno calcolato la frequenza di supernove nel raggio di 20 parsec (circa 65 anni luce) dal nostro pianeta, e l’hanno confrontata con la frequenza approssimativa di eventi di estinzione di massa attribuiti in precedenza a supernove vicine – escludendo, quindi estinzioni legate ad altri fattori, come l’impatto di asteroidi o le ere glaciali.
«Abbiamo calcolato la frequenza di supernove vicine alla Terra», spiega uno dei tre autori dello studio, Nick Wright, della Keele University, «e abbiamo visto che era consistente con la frequenza degli eventi di estinzione di massa sul nostro pianeta che erano stati collegati a forze esterne come le supernove». Una frequenza, per le supernove a collasso nucleare avvenute, come dicevamo, a non più di 20 parsec dalla Terra, pari a circa 2,5 eventi ogni miliardo di anni: compatibile, appunto, con le tempistiche delle due estinzioni di massa – quelle dell’Ordoviciano e del tardo Devoniano.
Le esplosioni di supernova sono estremamente potenti e rilasciano un’energia paragonabile a quella che produce il Sole nella sua intera esistenza, in grado di spazzare via tutto ciò che si trova nello spazio circostante. Se questo evento avvenisse vicino alla Terra sarebbe un disastro: la supernova potrebbe derubare l’atmosfera dell’ozono, innescare piogge acide ed esporre gli esseri viventi alle dannose radiazioni ultraviolette rilasciate dal Sole.
«Le esplosioni di supernova portano elementi chimici pesanti nel mezzo interstellare, dove vengono poi usati per formare nuove stelle e pianeti. Ma se un pianeta, inclusa la Terra, si trova troppo vicino a questo tipo di eventi, ciò può avere effetti devastanti», dice il primo autore dello studio, Alexis Quintana, attualmente all’Università di Alicante, sottolineando come le stelle massive – una supernova a collasso nucleare si ha quando una stella massiva raggiunge il termine della propria vita, finisce il carburante nucleare, si raffredda e infine collassa sotto la pressione della gravità – possano comportarsi sia da creatrici che da distruttrici di vita. Alle supernove è infatti anche attribuito un ruolo cruciale nello spargimento di elementi pesanti nell’universo, elementi essenziali per lo sviluppo della vita. Le supernove sono quindi da un certo punto di vista l’anello di congiunzione tra la morte di una stella e l’inizio della vita nell’universo, ma se l’ipotesi sostenuta dai ricercatori si rivelasse corretta questi spettacolari eventi astronomici sarebbero responsabili dell’annientamento della stessa vita che hanno contribuito a creare.
Gli astronomi stimano che una o due supernove, o forse anche meno, avvengano ogni secolo in galassie come la Via Lattea. La buona notizia è che ci sono solo due stelle a noi vicine che potrebbero diventare supernove nei prossimi milioni di anni: Antares e Betelgeuse. Ma per nostra fortuna entrambe le stelle sono a più di 500 anni luce da noi, e simulazioni informatiche hanno precedentemente suggerito che una supernova a tale distanza dalla Terra probabilmente non avrebbe effetti sul nostro pianeta.
Per saperne di più:
- Leggi su Monthly notices of the Royal Astronomical Society l’articolo “A census of OB stars within 1 kpc and the star formation and core collapse supernova rates of the Milky Way” di Alexis L. Quintana, Nicholas J. Wright e Juan Martínez García