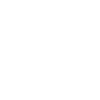Le stelle non sono solo oggetti celesti lontani, ma veri e propri testimoni del passato e del futuro dell’universo. Le loro “melodie cosmiche” rivelano segreti nascosti, offrendo uno sguardo unico sull’evoluzione della nostra galassia e sul destino che ci attende. È quanto afferma il team di ricerca guidato da Claudia Reyes, ricercatrice alla University of New South Wales (Unsw) di Sydney (Australia) e prima autrice di uno studio pubblicato oggi su Nature. Il lavoro ha analizzato 27 stelle che si trovano nell’ammasso stellare M67, situato a 2700 anni luce dalla Terra. Stelle nate tutte dalla stessa nube di gas, circa quattro miliardi di anni fa. Pur avendo una composizione chimica simile, presentano masse diverse, e questo le rende perfette per studiare l’evoluzione stellare come se la osservassimo in “tempo reale”, perché la velocità con cui le stelle evolvono dipende essenzialmente dalla loro massa.
«Quando studiamo le stelle in un ammasso, possiamo osservare l’intero processo evolutivo di ciascuna di esse», spiega Reyes, sottolineando come M67 sia in questo senso un ammasso speciale, perché include una vasta gamma di stelle “giganti”, che vanno dalle subgiganti più piccole e meno evolute, fino alle giganti rosse, stelle più mature.
«Studiare una sequenza evolutiva così lunga come quella che abbiamo osservato in questo ammasso è una novità assoluta», aggiunge Dennis Stello della Unsw, co-autore dello studio. «La principale difficoltà in astronomia è infatti determinare l’età di una stella, poiché non è la superficie a rivelarla, ma ciò che accade al suo interno».
Ciò che ha permesso, in questo studio, di determinare con precisione l’età e la massa delle stelle è stata la loro frequenza di oscillazione. Ogni stella “suona” a una frequenza unica, che dipende dalle proprietà fisiche del suo interno, come densità, temperatura e – per l’appunto – età. Gli scienziati hanno utilizzato i dati raccolti dalla missione Kepler K2 per “ascoltare” e misurare queste oscillazioni. «La frequenza con cui uno strumento vibra o “suona” risente delle proprietà fisiche del materiale attraverso cui il suono viaggia», prosegue Stello, «Per le stelle è lo stesso: è possibile “ascoltare” una stella in base al modo in cui vibra. Possiamo osservare la vibrazione, o l’effetto della vibrazione, del suono proprio come si può vedere la vibrazione di una corda di violino».
In particolare, le stelle più grandi emettono “suoni” più profondi, mentre quelle più piccole producono “suoni” acuti. Inoltre, nessuna di esse emette una sola nota: ogni stella genera una vera e propria sinfonia di suoni provenienti dal suo interno. Studiarle è dunque un po’ come ascoltare un’orchestra mentre suona una sinfonia e provare a identificare tutti gli strumenti che la compongono in base al suono.
Ma se nello spazio non esiste il suono, poiché privo di particelle che permettano la trasmissione delle vibrazioni acustiche, come hanno fatto gli scienziati ad “ascoltare” le stelle? Grazie alle fluttuazioni nella loro luminosità. «Ogni stella è come una palla di gas che respira, raffreddandosi e riscaldandosi, con lievi cambiamenti in luminosità», spiega Stello. «Sono queste fluttuazioni di luminosità ciò che abbiamo osservato e misurato per determinare le frequenze del suono».
Man mano che le stelle evolvono verso la fase di giganti rosse, le loro frequenze cambiano e assumono comportamenti differenti. Questi cambiamenti possono fornire informazioni sulla loro evoluzione e rivelare dettagli sulle loro proprietà interne. Studiando le 27 stelle dell’ammasso M67, i ricercatori sono riusciti per la prima volta a osservare la relazione tra le piccole e grandi differenze di frequenza nelle stelle giganti – relazione che ora può essere applicata anche a singole stelle.
Ad esempio, secondo gli autori, poiché le stelle di M67 hanno un’età e una composizione chimica simile a quelle del Sole, sono in grado di offrire informazioni cruciali sulla formazione e sull’evoluzione del nostro sistema solare, nonché sul destino della nostra stella. «Questo studio ci permette di penetrare nei meccanismi fisici più profondi che avvengono all’interno delle stelle», conclude Stello. «È importante per noi poter costruire modelli evolutivi di cui possiamo fidarci per predire cosa accadrà al Sole e ad altre stelle man mano che invecchiano».
Il prossimo passo per gli scienziati sarà analizzare queste “sinfonie” del cielo con un nuovo approccio, aprendo così nuove possibilità per comprendere meglio l’universo e le stelle che lo popolano. «Torneremo ad analizzare i dati raccolti negli anni passati per cercare queste frequenze particolari che nessuno aveva mai notato prima», conclude Reyes.
Per saperne di più:
- Leggi su Nature l’articolo “Acoustic modes in M67 cluster stars trace deepening convective envelopes” di Claudia Reyes, Dennis Stello, Joel Ong, Christopher Lindsay, Marc Hon e Timothy R. Bedding